 Recensione di Nel bosco, di Thomas Hardy
Recensione di Nel bosco, di Thomas Hardy
Fazi, Tascabili, 2003
Nel bosco è la traduzione italiana, secondo me approssimativa, del titolo del romanzo The Woodlanders, uscito originariamente a puntate sul mensile letterario Macmillan’s Magazine tra il maggio 1886 e l’aprile successivo, e pubblicato in tre volumi subito dopo. Nella cronologia dei romanzi di Hardy si colloca dopo Il sindaco di Casterbridge e prima di Tess dei d’Urberville, situandosi quindi nel periodo di massima qualità della sua produzione in prosa, che si sarebbe conclusa presto con Jude l’oscuro. The Woodlanders figura tra i Novels of character and environment, quelli che l’autore riteneva di maggior rilevanza artistica; egli lo amava particolarmente, tanto che ancora nel 1912 scrisse: ”avendolo riletto dopo molti anni mi è piaciuto soprattutto per la storia”.
Tornando al titolo, vi è da dire che la sua traduzione in italiano non si presenta facile: quella più ovvia, gli abitanti del bosco o della foresta non riesce infatti a rendere perfettamente lo status dei protagonisti, che non abitano nella foresta, ma ai suoi margini, e semmai traggono dalla foresta – oltre che i loro mezzi di sostentamento – anche il loro character. È però a mio avviso indubbio che Nel bosco fa perdere del tutto l’evocatività del titolo originale, soprattutto perché nasconde il fatto essenziale che il libro si interessa di una piccola comunità umana: forse, non fosse per il fatto che il termine denota una precisa professione, una possibile buona traduzione potrebbe essere I boscaioli.
Il romanzo narra infatti le vicende degli abitanti di Little Hintock, piccolo e sperduto villaggio situato ai margini di una vasta area boschiva, tra coltivazioni di meli, nel sudovest dell’Inghilterra. Siamo nel cuore del Wessex, la regione rurale nella quale sono ambientate molte delle storie narrate da Hardy. Wessex è l’antico nome di una regione dai confini non ben definiti, delimitata grossomodo da Bristol e Bath a nord, dalla linea che unisce Oxford a Southampton a est e dalla costa della Manica sino a Plymouth a sud e corrispondente oggi alle contee del Dorset, dello Wiltshire, del Somerset, del Devon, dell’Hampshire, oltre a parti del Berkshire e dell’Oxfordshire. È una delle regioni più cariche di storia della Gran Bretagna: entro i suoi confini si trovano tra l’altro il complesso megalitico di Stonehenge e i meravigliosi geoglifi di Uffington e Cerne Abbas; numerosi insediamenti che chiudono il loro nome con il suffisso -chester (da castrum) testimoniano come essa sia stata uno dei fulcri della colonizzazione romana dell’isola; molte città conservano preziosi centri storici medievali e numerose sono i resti di abbazie che punteggiano il paesaggio. Ancora oggi la regione presenta, soprattutto all’interno, un carattere essenzialmente rurale, essendo sfuggita alle ondate di industrializzazione succedutesi a partire dal XVIII secolo. Hardy ne ha fatto una regione dell’anima, nella quale si ritrovano le dinamiche sociali e psicologiche che è interessato a mettere in luce nelle sue opere, e che per lui assumono un carattere universale. Ecco cosa afferma in proposito nella Prefazione generale all’edizione Wessex (traduzione mia): “A volte si ritene che i romanzi che sviluppano la loro azione nell’ambito di una scena circoscritta – come fanno molti di questi (sebbene non tutti) – non possano essere tanto esaustivi nell’analizzare la natura umana quanto i romanzi le cui ambientazioni spaziano lungo vaste estensioni del paese, i cui eventi interessano paesi e città, riguardando a volte i quattro quarti del globo. Non mi preoccupa discutere ulteriormente questo punto, se non per suggerire che tale concezione non è vera rispetto alle passioni elementari. Vorrei però affermare che i limiti geografici delle loro ambientazioni non sono stati assolutamente imposti all’autore da mere circostanze; egli le ha imposte a se stesso sulla base di un giudizio. Ritenevo che la nostra splendida eredità nella letteratura drammatica, risalente ai Greci, potesse trovare sufficiente spazio in un’area non molto più grande della mezza dozzina di contee qui riunite sotto l’antico nome di Wessex; che le emozioni interiori abbiano pulsato nei reconditi angoli del Wessex con la stessa intensità che nei palazzi d’Europa, e che, in ogni caso, nel Wessex ci fosse sufficiente natura umana per soddisfare le finalità letterarie di uno scrittore”.
Il Wessex come microcosmo rappresentativo dell’universo sociale e umano, quindi, ed anche, grazie alla sua arretratezza, luogo in cui le passioni elementari possono emergere ad un livello più puro”.
Sempre nella Prefazione generale Hardy informa del modo in cui ha ridisegnato la toponomastica della regione, mantenendo i nomi delle grandi città ai suoi confini (Bristol, Bath, Plymouth, Southampton) e dello sfondo topografico (alture, fiumi, valli) e rinominando invece tutti gli insediamenti umani al suo interno; molti esegeti si sono esercitati nel corso del tempo a riconoscere i luoghi in cui sono ambientati i romanzi del Wessex, e lo stesso Hardy ci fornisce un campione di questo esercizio, dai quali si evince ad esempio che la città in cui è ambientato gran parte de Il sindaco di Casterbridge corrisponde effettivamente a Dorchester. Tenterò di farlo anch’io riguardo ai luoghi in cui si svolge Nel bosco, perché senza dubbio è un esercizio divertente e di indubbio fascino.
Nell’incipit del romanzo Hardy fornisce al lettore alcuni precisi indizi: ”Il viaggiatore che per qualche antico legame dovesse percorrere la vecchia strada carrabile che traccia un linea quasi meridiana da Bristol fino alla costa meridionale dell’Inghilterra, a metà del cammino si troverebbe in prossimità di certe vaste distese di boschi, cosparse di campi di meli”. Più avanti, viene detto che una carrozza unisca i centri di Sherton e Abbot’s Cernel, che nella toponomastica del Wessex sappiamo corrispondere rispettivamente alle cittadine di Sherborne e Cerne Abbas, nel Dorset, distanti tra loro poco più di dieci miglia, come indicato nel romanzo. Circa a metà strada tra loro si trova effettivamente una estensione boschiva, detta >i>Greenfield forest, ai cui margini occidentali sorge il piccolo villaggio di Hermitage, probabilmente preso a modello da Hardy per Little Hintock. Di meleti, se mai ve ne sono stati, nell’area oggi non v’è traccia.
Vi è comunque da aggiungere che Hardy si diverte, nella sua prefazione all’edizione del 1912 del romanzo, a confessare che egli stesso non sa dire dove si trovi il villaggio, e che una volta passò molte ore in bicicletta in compagnia di un amico per cercarlo, non riuscendovi.
Continua a leggere “Per quanto a nord tu sia nato, sei sempre il terrone di qualcun altro”

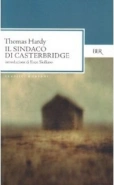 Recensione de Il sindaco di Casterbridge, di Thomas Hardy
Recensione de Il sindaco di Casterbridge, di Thomas Hardy Recensione de La chiave di vetro, di Dashiell Hammett
Recensione de La chiave di vetro, di Dashiell Hammett Recensione de Il pomeriggio di un piastrellista, di Lars Gustafsson
Recensione de Il pomeriggio di un piastrellista, di Lars Gustafsson Recensione di Trans-Atlantico, di Witold Gombrowicz
Recensione di Trans-Atlantico, di Witold Gombrowicz Recensione de Il giorno del silenzio, di George Gissing
Recensione de Il giorno del silenzio, di George Gissing Recensione de I falsari, di André Gide
Recensione de I falsari, di André Gide Recensione di Passaggio in India, di Edward Morgan Forster
Recensione di Passaggio in India, di Edward Morgan Forster Recensione di Joseph Andrews, di Henry Fielding
Recensione di Joseph Andrews, di Henry Fielding